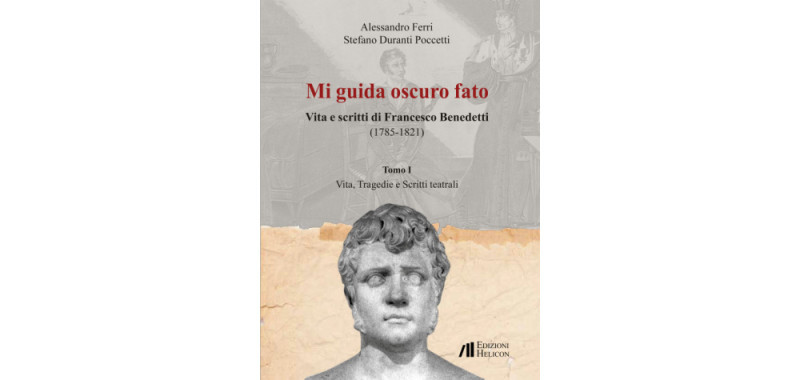Alessandro Ferri – Stefano Duranti Poccetti, Mi guida oscuro fato. Vita e scritti di Francesco Benedetti (1785-1821), t. I (Vita, Tragedie e Scritti teatrali), Arezzo, Helicon, 2023
Le lapidi commemorative otto-novecentesche, con la loro retorica d’antan e l’altisonante ampollosità del loro lessico ricercato, destano non di rado oggi un misto di curiosità e compatimento nei pochi passanti che si soffermano a leggere – e si sforzano d’interpretare – quelle espressioni irrimediabilmente démodé, voci di un remoto passato del quale vorrebbero – e dovrebbero – perpetuare la memoria, un passato che invece, il più delle volte, rimane confinato nelle segrete dell’oblio; eppure esse testimoniano, meglio d’ogni altro documento, il credito in cui sono stati tenuti dalle istituzioni pubbliche personaggi additati, per motivi politici o culturali, come esempio ai cittadini vissuti in quel determinato momento storico e alle generazioni future. Orbene, nel 1921, in occasione del primo centenario della morte del poeta cortonese Francesco Benedetti, di fronte al Ginnasio a lui intitolato, viene apposta una pomposa iscrizione nella quale si legge: «Amor di patria odio ai tiranni / persecuzione e tradimenti / foggiarono / in / Francesco Benedetti / l’apostolo lo scrittore il martire / i Cortonesi / nel centenario del suo sacrificio / vollero ricordarlo / alla gioventù italiana / 1ͦ maggio 1921» (p. 69). Ma se «l’apostolo» e «il martire» trovano giustificazione rispettivamente nell’«amor di patria» e nell’«odio ai tiranni», «lo scrittore» rimane, per così dire, ‘scoperto’, senza alcuna menzione delle opere nelle quali, si suppone, egli deve aver lasciato traccia delle virtù patrie tanto decantate. Ecco, in questa epigrafe, per quel che dice – e, ancor più, forse, per quel che tace –, si può cogliere il dramma di un poeta, il Benedetti, il cui ricordo è stato di fatto fagocitato da quegli ideali politici che lo condussero al fatale colpo di rivoltella con cui pose fine ai suoi giorni in quel Calendimaggio 1821 – giusto quattro giorni prima della scomparsa dell’amato-odiato Bonaparte a Sant’Elena.
A colmare le lacune della memoria collettiva – e le omissioni delle stele marmoree –, ecco finalmente un volume dal taglio volutamente divulgativo, Mi guida oscuro fato. Vita e scritti di Francesco Benedetti (1785-1821), che fa luce sull’attività più notevole del Cortonese, quella di tragediografo. Si tratta di un’impresa editoriale di vasta portata – oltre 500 pagine – sapientemente concepita e realizzata da Alessandro Ferri e Stefano Duranti Poccetti, che già adesso si pone come uno spartiacque nella storia degli studi benedettiani – storia fin qui limitata, certo, a un numero di scritti critici obiettivamente esiguo, ma che da questo momento in avanti confidiamo che potrà dar modo ad altri ricercatori di approfondire la personalità e l’opera del Benedetti. Oltre a una ricca biografia e alla bibliografia completa dell’autore, infatti, il tomo presenta la sinossi di tutte le tragedie, una selezione dei brani ritenuti più rappresentativi di esse con annessa la crestomazia della critica nonché i testi di teoria teatrale in versione integrale (il Discorso intorno al Teatro italiano, il Discorso sulla necessità di un Teatro nazionale e la corrispondenza epistolare col conte Galeani Napione).
Va precisato anzitutto un dato che rischierebbe di dare adito a degli equivoci: i redattori del volume sono ambedue concittadini del Benedetti, è vero, ma contrariamente a quanto accade di solito, quando editori locali valorizzano lo sconosciuto genius loci onde proporlo all’ammirazione dei loro conterranei, Ferri e Duranti Poccetti, con lodevole acribia critica e notevole spessore intellettuale, delineano un ritratto oggettivo, per niente retorico e celebrativo del personaggio, sì da sottrarlo a quelle semplificazioni di taglio risorgimentale e post-risorgimentale interessate a dipingerlo più come un emblema politico che come un letterato. Beninteso: il suicidio del Benedetti, braccato dalla polizia granducale e da tempo ostracizzato per la schiettezza con cui manifestava i suoi ideali, ha certamente una grande importanza. Esso rappresenta probabilmente l’inevitabile approdo del modo viscerale con cui il poeta sentiva e viveva entro di sé i problemi politici e sociali del suo tempo, e riteniamo altresì che la sua morte costituisca il finale perfetto della più bella tragedia da lui composta, quella della sua esistenza, scritta col suo stesso sangue: l’essere divenuto martire della libertà, al pari di un eroe tragico, ha realmente trasformato la sua vita in un’opera d’arte. D’altre parte, se negli anni immediatamente precedenti e poi successivi all’Unità d’Italia era comprensibile e forse persino giustificabile un approccio di questa natura, oggi certamente non possiamo più accontentarci di celebrare «l’apostolo» e «il martire»: è allo scrittore che dobbiamo guardare, e per farlo dobbiamo leggere le sue opere e riflettere sul loro significato. È appunto questo lo scopo perseguito da Mi guida oscuro fato, che vuol essere, più che un punto d’arrivo, un punto di partenza, come conferma la volontà di Ferri e Duranti Poccetti di procedere alla pubblicazione di un II tomo contenente le Rime e le prose non teatrali del Benedetti. Ovviamente nessuno si aspetta che egli divenga ipso facto familiare al grande pubblico quanto altri letterati – e drammaturghi – vissuti in quella medesima temperie storica, da Alfieri a Monti, da Pindemonte a Foscolo, sarebbe ingenuo supporlo; e tuttavia la damnatio memoriae toccatagli in sorte è inammissibile a fronte di una produzione che qualitativamente si pone come una delle più interessanti dell’epoca.
Essa appare altresì sorprendente da un punto di vista quantitativo, considerando il breve giro d’anni in cui poté estrinsecarsi. E come non pensare qui, mutatis mutandis, a un altro grande scrittore italiano morto ancor più giovane eppure egualmente prolifico, Ippolito Nievo? A Benedetti potrebbe applicarsi quanto il padre dell’autore delle Confessioni d’un Italiano ebbe a dichiarare all’indomani della prematura scomparsa del figlio: «…poté in un corso di vita breve e fortunosa dar fuori tanti scritti e tanti lasciarne inediti, perché non si distraeva mai dalle meditazioni e in ogni ritaglio di tempo lavorava, portando in tutte le circostanze, sopra ogni fatto, anche comune, l’osservazione più fine e minuta e la critica più penetrante…». A questo proposito, risulta particolarmente interessante una Notizia delle opere di Francesco Benedetti da Cortona apparsa sull’Antologia del Vieusseux nel settembre 1821 in cui, dopo aver manifestato la propria meraviglia per «la […] copia e varietà di scritture uscite dalla sua penna» in un sì breve e travagliato lasso di tempo, l’anonimo redattore, commentando l’intenzione dei fratelli del poeta di pubblicarne gli opera omnia – progetto poi ridottosi alle sole tragedie, edite nel 1822 –, precisa: «[…] noi preghiamo i signori Teodoro e Antonio Benedetti (lodando e applaudendo al nobile loro divisamento), che essi vogliano in particolar modo intendere a onorar la memoria del loro fratello più colla scelta che colla copia delle scritture da pubblicarsi» (p. 58). Ecco, sembra quasi che gli autori del nostro volume abbiano realizzato quanto auspicato a suo tempo dall’Antologia proponendo non un’edizione integrale del teatro benedettiano – che pure sarebbe in futuro auspicabile, magari, chissà, un’edizione nazionale –, bensì una selezione delle sue tragedie, ciascuna delle quali preceduta da un’ampia introduzione in cui i nostri ricercatori si confrontano con la critica del passato (a volte, inevitabilmente, di un passato assai remoto). Proprio quest’ultimo aspetto mette in evidenza un dato assai interessante: probabilmente non esiste un letterato in Italia sul quale i giudizi risultino tanto contrastanti, non di rado antitetici, del tutto inconciliabili. Una sì vistosa differenza di vedute circa la produzione benedettiana dipende forse dalla difficoltà di inquadrare il Cortonese nel panorama culturale d’inizio Ottocento – panorama già di per sé assai variegato e complesso, in cui fioriscono esperienze diversissime sia sul piano stilistico che su quello ideologico. Il problema principale riteniamo derivi dal fatto che il Nostro vive in un momento di transizione (anche piuttosto convulsa) della nostra letteratura, tra un retaggio classicistico cui egli rimane orgogliosamente fedele e un romanticismo incipiente fieramente avversato, sì, ma alle cui suggestioni neppure lui rimane completamente insensibile – e ci riferiamo qui non solo al Cola de Rienzo, l’ultima e più moderna delle sue tragedie, ma soprattutto a certi topoi tipicamente romantici quali la scena di pazzia, usati e abusati dal nostro teatro tragico e dal nostro melodramma per buona parte del Primo Ottocento. Accade così che in questo o quel lavoro del Benedetti taluno preferisca ravvisare i legami con la cultura classica e talaltro ne individui i prodromi di un’imminente palingenesi. E può ben darsi che abbiano ragione entrambi, poiché egli sembra continuamente oscillare fra tradizione e innovazione, tra fedeltà a vecchi modelli e istanze di rinnovamento. Tale oscillazione non si ravvisa, viceversa, in ambito politico-ideologico: la sua costante professione di fede in un giacobinismo ortodosso, decisamente fuori tempo massimo date le mutate condizioni dell’Europa dopo Waterloo, contribuisce peraltro a isolarlo anche fra i patrioti italiani del tempo.
Il volume si raccomanda altresì per un ricco apparato di note in cui confluiscono notizie che contribuiscono a inquadrare meglio il Benedetti nei rapporti con il mondo intellettuale coevo. Di grande interesse risulta in tal senso una lettera dell’agosto 1818 di Silvio Pellico (anch’egli affiliato alla Carboneria, seppure alieno da qualunque forma di estremismo ideologico, e finito parimenti nel tritacarne della Reazione giusto un anno prima del Benedetti, nel 1820): in essa il Saluzzese esorta il fratello Luigi alla lettura delle liriche del Nostro descrivendolo come un «uomo che pensa liberamente, e scrive come pensa» e apprezzandone l’«ingegno e l’animo» (p. 90). Non meno rilevante è poi il presunto ruolo che Antonio Morrocchesi avrebbe avuto nel fiasco della Gismonda, l’ultima opera benedettiana allestita sulle scene, in merito alla cui caduta il Cortonese punta il dito contro il noto attore e maestro di recitazione asserendo in una lettera all’amico Lorini nel 1817: «egli, per un’infamia propria del suo antico mestiere, e per una gelosia d’arte (giacché costui la pretende, lo crederesti?, ad autore) mi ha fatto una cabala per cui la Gismonda non si è recitata» (p. 91). Ora, il fatto che Morrocchesi si fosse improvvisato drammaturgo dopo il suo ritiro dalle scene malgrado fosse del tutto sprovvisto di talento letterario è certamente vero, ma che fosse geloso del talento del Benedetti, peraltro ‘esibito’ in un’opera decisamente minore come la Gismonda appare poco credibile. Per spiegare l’insuccesso della tragedia è sufficiente leggerla, non occorre evocare complotti e trame occulte. Questo dimostra ancora una volta quanto discontinua risulti la produzione teatrale benedettiana, ove testi di grande fascino quali Mitridate, Pelopea e Cola de Rienzo si affiancano ad altri assai meno ispirati. Cionondimeno, la riscoperta della produzione tragica del Cortonese è fondamentale almeno come documento, come testimonianza di un gusto e di un approccio ideologico. Ben vengano, dunque, iniziative editoriali quali quella intrapresa da Ferri e Duranti Puccetti, che rappresentano già adesso un formidabile impulso allo studio e alla divulgazione delle opere benedettiane.
Ignazio Castiglia